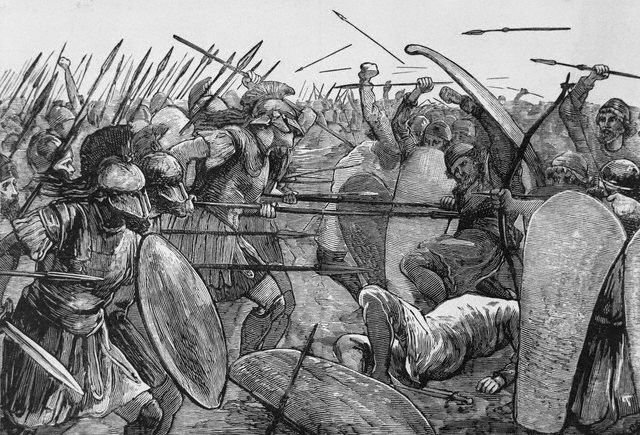Partecipanti, date e risultato
Partecipanti: Atene e Sparta
Inizio: 431 a.C
Fine: 404 a.C
Esito: Vittoria Spartana
Personaggi
- Pericle (politico ateniese)
- Cleòne (generale Ateniese)
- Alcibìade (generale Ateniese)
- Archidàmo II (re spartano)
- Bràsida (generale spartano)
- Lisàndro (generale spartano)
- Callicratìda (generale spartano)
Battaglie principali
- Battaglia di Anfìpoli, 424 a.C (vittoria spartana)
- Battaglia di Mantinea, 418 a.C (vittoria spartana)
- Assedio di Siracusa, 415 a.C (vittoria Siracusana)
- Battaglia di Cìzico, 410 a.C (vittoria ateniese)
- Battaglia di Nozio, 406 a.C (vittoria ateniese)
- Battaglia di Egospòtami, 405 a.C (vittoria spartana)
CRONOLOGIA DELLA GUERRA DEL PELOPONNESO
INIZIO. 431 a.C
Gli Spartani invadono l’Attica e assediano Atene. Scoppia epidemia ad Atene, muore Pericle.
Il demagogo ateniese Cleone e il generale spartano Brasida, si combattono. Gli spartani vincono, ma muoiono entrambi i generali.
Pace fra Atene e Sparta per 50 anni
Alcibiade, nipote di Pericle, convince Atene a conquistare la Sicilia e a combattere contro Siracusa, alleata di Sparta
Le statue del Dio Ermes vengono mutilate. Alcibiade viene accusato e passa dalla parte degli Spartani.
Senza Alcibiade, i generali ateniesi Nicia e Lamaco assediano Siracusa senza successo e perdono la flotta.
Alcibiade si allea con i persiani contro Atene, ma medita di tornare. Interviene contro il colpo di stato in città e viene perdonato dai concittadini.
Alcibiade sconfigge gli Spartani in una battaglia navale a Cizico, e torna trionfante ad Atene.
Alcibiade commette un errore madornale, e la flotta ateniese viene distrutta dal generale spartano Lisandro. Alcibiade viene annientato politicamente e Atene sprofonda nel caos politico.
Con gli ultimi sforzi, Atene vince una battaglia navale contro gli spartani di Callicratìda, ma le lotte politiche interne vanificano la vittoria.
Lisandro sorprende la flotta ateniese e la distrugge. La disfatta militare ateniese è completa.
Lisandro marcia su Atene e la assedia. La città si arrende. Instaurazione del regime dei “Trenta Tiranni”.
FINE. 404 a.C
Atene era il punto di riferimento della regione dell’Attica. Dotata di strutture politiche all’avanguardia e animata da una finissima vivacità culturale, sotto l’aspetto economico aveva una debole agricoltura, per via della scarsità delle terre coltivabili, ma grazie ai fiorenti commerci le sue finanze erano ottime, tanto che all’inizio della guerra Atene aveva novemila talenti d’oro conservati nelle casse della città.
Sotto il profilo militare, Atene poteva contare su un’ottima flotta navale e sull’alleanza di tutte le città appartenenti alla regione delio-attica, mentre l’esercito di terra era ridotto.
Sparta aveva una struttura sociale profondamente militare e una secolare cultura guerriera, mentre era meno dedita alla filosofia e alla cultura politica. Il suo esercito, che aveva a disposizione una consistente fanteria, era molto forte nelle battaglie sul territorio. Anche Sparta poteva contare su una serie di alleanze con le città appartenenti alla lega del Peloponneso.
Per contro, Sparta non aveva mai avuto delle floride finanze e non aveva mai sviluppato una propria flotta, tanto è vero che, in caso di bisogno, utilizzava le navi degli alleati di Corinto.
Secondo lo storico contemporaneo Tucidide, le cause della guerra del Peloponneso dipendono dalla crescente influenza che Atene stava esercitando sulla zona. Gli ateniesi avevano la chiara intenzione di dominare il territorio a tutto danno degli Spartani, che da anni si preparavano alla guerra per ridimensionare l’importanza di Atene.
Il Casus Belli fu di natura commerciale: la lega Attica, dominata da Atene, e la lega del Peloponneso, dominata da Sparta, avevano stretto da decenni degli accordi di libero scambio per favorire i commerci. La ricchezza stessa del territorio dipendeva dai continui scambi tra le città appartenenti alle due leghe.
Nel 431 a.C Pericle, il leader politico di Atene, rimosse le autorizzazioni al commercio nei confronti della città di Megara, appartenente alla lega del Peloponneso, sanzione che, in quel tessuto economico, equivaleva a condannare la città alla rovina.
Sparta comprese perfettamente che si trattava di una provocazione, e diede ad Atene un ultimatum: gli accordi dovevano essere immediatamente ristabiliti o si sarebbe arrivati al conflitto. Al diniego da parte di Pericle, si arrivò alla dichiarazione di guerra.
L’iniziativa partì dalla città di Sparta: il suo re Archidamo II si alleò con la città di Tebe e marciò attraverso il territorio dell’Attica contro Atene.
Gli ateniesi preferirono rifiutare lo scontro sul terreno e scelsero di ritirarsi, assieme agli abitanti delle campagne, all’interno delle mura della città. Iniziò così un assedio lungo mesi, che fu colmo di sofferenze sia per via della fame, sia sotto l’aspetto psicologico, dal momento che gli ateniesi erano costretti a guardare, impotenti, mentre gli spartani devastavano i loro territori.
Durante la reclusione forzata, scoppiò persino una violenta epidemia di peste, che decimò gli ateniesi e portò alla morte dello stesso Pericle.
Nonostante questo, i generali ateniesi ottennero alcune vittorie militari: lo stratego Formione sconfisse i Corinzi, venne soffocata la rivolta di Mitilene, capoluogo dell’isola di Lesbo, e il generale Demostene conquistò l’isola di Sfacterìa, mentre il generale Nicia conquistò l’isola di Citèra.
Privi del loro leader politico, ad Atene si aprì il dibattito per scegliere i nuovi comandanti. I due candidati erano Cleone, democratico e favorevole alla prosecuzione della guerra contro Sparta, e Nicia, conservatore ed aristocratico, più disposto ad una pace con il nemico. Con la vittoria di Clone, Atene rifiutò ogni compromesso con Sparta e la guerra proseguì.
Gli Spartani e i loro alleati tebani continuarono con la strategia di attacco via terra, guidati dal generale Spartano Brasida. Egli ottenne diverse vittorie contro le città della lega di Delo, fino allo scontro definitivo, la battaglia di Anfipoli, in cui sia Cleone che Brasida morirono sul campo.
Senza i due leader che più avevano spinto per la guerra, ateniesi e spartani concordarono la pace di Nicia, che manteneva intatti i rispettivi possedimenti territoriali e rinunciava all’uso delle armi per i successivi 50 anni.
Ad Atene, il dibattito sul da farsi non si era mai fermato ed il generale Alcibiade, nipote di Pericle, emerse come la più importante figura militare e politica. Egli non aveva alcuna intenzione di onorare la pace di Nicia, e anzi desiderava riprendere la guerra contro Sparta, elaborando una raffinata strategia contro il nemico.
Innanzitutto il disegno di Alcibiade mirava a disarticolare le principali alleanze che Sparta aveva con le città vicine. Lo stratega riuscì a portare dalla sua parte le città di Argo e di Mantinea, oltre a tutta la Regione dell’Elide.
Sparta, vedendosi isolata, ricorse nuovamente al suo esercito, che affrontò quella ateniese nella battaglia di Mantinea, che si concluse con una netta vittoria degli spartani.
Alcibiade fu quindi costretto a cambiare la propria strategia e decise di dirottare le forze ateniesi verso la Sicilia. I motivi della sua decisione risiedevano nel fatto che la città siciliana di Siracusa, fiorente nei commerci e forte militarmente, era alleata degli spartani e avrebbe potuto presto dare manforte al nemico. Inoltre, un’invasione della Sicilia avrebbe assecondato l’antico disegno ateniese di espandersi con delle colonie nel sud Italia.
Ad Alcibiade serviva solamente una scusa per intervenire nell’isola, e questa gli venne offerta dalle contese fra le città del luogo: Siracusa appoggiava infatti la città di Selinunte, la quale minacciò di invadere Segesta, alleata di Atene. Vedendosi in pericolo, Segesta richiese l’aiuto militare degli alleati greci, che Alcibiade fu ben contento di offrire.
I preparativi per la spedizione in Sicilia erano già avviati: i tre generali alla guida della missione sarebbero stati Alcibiade e i generali Nicia e Lamaco, con 136 navi da guerra a loro disposizione. Poco prima della partenza, tuttavia, si verificò uno scandalo.
Durante la notte, le statue raffiguranti il dio Hermès, disseminate per tutta Atene, vennero brutalmente mutilate. Si sparse la voce che i responsabili di questa gravissima offesa al Dio erano stati i sostenitori di Alcibiade.
Comprendendo che si trattava di una manovra politica per eliminarlo, Alcibiade scappò da Atene per evitare un processo farsa che lo avrebbe sicuramente visto come condannato, e decise di cambiare completamente sponda, rifugiandosi a Sparta ed offrendo ai suoi nemici tutte le sue conoscenze e il suo supporto strategico.
Così, gli Spartani misero immediatamente Alcibiade al comando della guerra in Sicilia, contro i suoi ex concittadini: mentre gli Spartani di Alcibiade e la città di Siracusa combattevano con fermezza, Nicia, mai convinto delle possibilità di successo in Sicilia e Lamaco, altrettanto insicuro, eseguirono un incerto e disorganizzato assedio a Siracusa, che si concluse con un fallimento.
Arrivati infine ad una grande battaglia navale, la flotta ateniese venne completamente distrutta. Per Atene fu probabilmente una delle peggiori sconfitte durante la guerra del Peloponneso.
Ad Alcibiade, dopo il fallimento ateniese in Sicilia, venne affidato con entusiasmo il compito di guidare la strategia spartana per il resto della guerra. Ed egli decise di attuare una tattica che mirava a “strozzare” Atene.
Innanzitutto fece eseguire un attacco militare nei confronti della fortezza di Decelea, dalla quale partivano i rifornimenti di cibo per gli ateniesi. Inoltre fece conquistare le miniere di argento della regione del Laurio, colpendo il nemico anche sotto l’aspetto economico.
Nel frattempo, eseguì una abilissima attività diplomatica per sottrarre alleati agli ateniesi: le città della regione dell’Eubea, l’isola di Lesbo, e le città di Chio, Efeso, Mileto e Mitilene passarono dalla parte degli spartani.
Inoltre, con mossa geniale, prese contatti con Tissaferne, abile diplomatico dell’Impero Persiano. Gli Spartani e i Persiani elaborarono una strategia congiunta per eliminare definitivamente gli ateniesi della Grecia e poi spartirsi il territorio.
In questo modo, Alcibiade riuscì a garantirsi l’alleanza del potente Impero persiano e soprattutto, grazie ai loro finanziamenti, risolse l’annoso problema della mancanza di denaro, che aveva sempre limitato le scelte degli spartani.
Tuttavia, mentre Atene concentrava le proprie forze per una difesa, nella politica spartana fiorivano i dissensi. In particolare, le iniziative di Alcibiade cominciarono ad essere gravemente osteggiate dal capitano spartano Astioco.
Alcibiade, infatti, stava suggerendo a Tissaferne di limitare gli aiuti agli spartani, sia per prolungare la guerra e il suo comando, ma soprattutto perchè, intanto, aveva maturato il desiderio di riconciliarsi con gli ateniesi.
Gli spartani, intuendo il doppio gioco di Alcibiade, ordinarono ad Astioco di arrestarlo ed Alcibiade decise di scappare, rifugiandosi da Tissaferne.
La posizione di Alcibiade era tuttavia problematica: dopo aver tradito gli ateniesi e aver offerto un fondamentale aiuto agli Spartani, era per lui impossibile ritornare in città.
Un modo ragionevole per poter ottenere il perdono dei suoi concittadini sarebbe stato quello di convincere i Persiani ad allearsi con Atene contro Sparta, ma le sue manovre diplomatiche fallirono.
La giusta occasione si presentò nel 411 a.C. Gli alti politici ateniesi iniziarono a far girare la voce che i Persiani si sarebbero alleati con Atene solo se questa avesse abolito la sua tradizionale democrazia e avesse eseguito una riforma costituzionale, imponendo un maggior controllo sulla cittadinanza.
Si verificò quindi un autentico colpo di stato, guidato dal generale Pisandro. Ma il nuovo Governo era estremamente impopolare, e gli ateniesi non erano disposti a sacrificare la loro forma politica pur di avere l’alleato persiano dalla loro parte. Alcibiade, che secondo alcuni autori era uno dei cospiratori stessi del colpo di stato, si presentò come il principale punto di riferimento per il ritorno alla democrazia, che avvenne nel giro di poco meno di un anno.
Così Alcibiade, considerato il difensore della democrazia ateniese e l’unico in grado di guidare la città alla vittoria nella guerra, fu acclamato e perdonato dai suoi concittadini e a lui vennero immediatamente affidati i pieni poteri per proseguire la guerra.
Tuttavia, Alcibiade preferì ottenere una vittoria militare prima di fare ufficialmente rientro in città. L’occasione si presentò nel corso di una battaglia navale tra la flotta di Alcibiade, Trasibulo e Teramene contro il generale spartano Mindaro, nei pressi di Cizico.
Gli Spartani stavano pattugliando le zone marittime dell’Ellesponto, quando Alcibiade utilizzò una piccola porzione della flotta ateniese come esca, attirando ed intrappolando il nemico, che venne completamente annientato.
La flotta spartana si era dissolta nel nulla, e gli ateniesi avevano ottenuto un successo di notevole importanza ai fini della guerra.
La guerra sembrava volgere a favore degli ateniesi, quando sulla scena comparve il nuovo generale Spartano, Lisandro, al comando di settanta triremi da guerra e appoggiato da Ciro il giovane, figlio del re persiano Dario.
Alcibiade lo affrontò militarmente nella battaglia di Nozio. Tuttavia quest’ultimo, anziché supervisionare personalmente la flotta ateniese, decise di delegare una parte del comando al suo luogotenente Antioco, dandogli la precisa istruzione di non attaccare battaglia contro il nemico. Sembra invece che Antioco, credendo di avere a disposizione un’occasione fortunata, abbia disatteso il suo ordine.
Lisandro ne avrebbe così approfittato, infliggendo agli ateniesi una importante sconfitta. Alcibiade fu nuovamente costretto a fuggire, temendo un processo nei suoi confronti.
In realtà la sconfitta nella battaglia di Nozio non fu tatticamente irreparabile, ma rappresentò un’ottima occasione per gli avversari politici di Alcibiade per prendere il potere in città. Tutti i suoi alleati, i principali strateghi e i consiglieri di Alcibiade vennero rimossi dai loro incarichi e il governo di Atene fu sostituito da un consiglio di dieci strateghi.
Nonostante i continui rivolgimenti politici, Atene, fondendo le statue d’oro degli Dei e ricorrendo ad un massiccio arruolamento, anche degli schiavi e degli stranieri, i meteci, riescì a costituire una flotta di 150 navi che si misurò contro il generale spartano Callicratìda.
Gli ateniesi ottennero una vittoria marittima importante, che avrebbe potuto essere risolutiva, o che perlomeno gli avrebbe permesso di trattare la pace con gli Spartani da una posizione di forza.
Eppure, la politica ateniese era ormai completamente in avvitamento: le sterili polemiche sul mancato salvataggio dei naufragi ateniesi durante la battaglia, degenerarono in una serie di pesanti lotte intestine, nel dilagare di procedure completamente illegali e in sommarie condanne a morte, che fecero precipitare Atene nel più assoluto caos.
Alla totale confusione politica, si aggiunse una improvvisa sconfitta militare. Mentre la flotta ateniese nei pressi di Egospotami era impegnata a cercare del cibo, venne sorpresa di nuovo dal generale Lisandro: le navi ateniesi furono completamente distrutte e i prigionieri, nonostante implorassero pietà, vennero brutalmente massacrati.
Atene era perduta: non vi era più alcuna forza militare in grado di opporsi agli Spartani di Lisandro, che decse di marciare contro la città, consapevole di non incontrare particolare resistenza.
Atene venne messa rapidamente sotto assedio e capitolò dopo poco tempo, ormai priva di forze. Fu condannata a dover abbattere le proprie mura, gli venne fatto divieto di ricostruire la propria flotta e gli fu tolta ogni autonomia politica.
Iniziò per Atene il famigerato “Regime dei trenta tiranni”, una forma di governo tirannica, guidata dal severissimo Crizia, e severamente controllata a distanza da Sparta.
La guerra del Peloponneso era finita.
Roberto Trizio
Consulente di comunicazione e web reputation, Roberto Trizio è il fondatore del gruppo divulgativo Scripta Manent. Attraverso sette canali, il network offre ogni giorno documentari e approfondimenti dall’epoca antica all’età contemporanea. Il gruppo, con 300.000 iscritti e oltre 1.5 mln di spettatori mensili, è leader in Italia per la divulgazione storica.
Articoli correlati
Battaglia di Hattin
La battaglia di Hattin ebbe luogo il 4 luglio 1187, tra gli stati crociati del Levante e le forze del